BRIAN ENO
IL NON-MUSICISTA UNIVERSALE
Tra i grandi nati nel mese di maggio c'è anche Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno, per gli amici solo Brian Eno, anzi Eno.
Nato il 15 maggio 1948 nel Suffolk (Inghilterra), Brian Eno più che un musicista, è un artista pluri-sfaccettato e innovativo, un architetto del suono, un visionario della musica contemporanea, figura centrale e rivoluzionaria del secondo Novecento e oltre. Polistrumentista, compositore, produttore, teorico e artista multimediale, Brian Eno ha ridefinito i confini dell’ascolto, portando la sperimentazione sonora in territori prima inesplorati, con una visione che ha influenzato profondamente non solo la musica ambient, di cui è considerato il padre fondatore, ma anche il rock, il pop, l'elettronica, la musica generativa e l'arte sonora.
Studia pittura e teoria musicale alla Ipswich Art School e successivamente al Winchester Art College, dove si avvicina a John Cage e alla musica aleatoria. Nel 1971 entra nella band Roxy Music, inizialmente come tecnico del suono e manipolatore elettronico. Il suo ruolo era tutt’altro che convenzionale: non suonava strumenti tradizionali, ma processava in tempo reale le sonorità con un sintetizzatore EMS VCS 3 dando vita ad effetti impressionanti, nuovi e straordinari. Nonostante la sua presenza scenica, corredata di piume e make-up, lo rendesse visivamente iconico ed istrionico, il suo contributo principale fu sonoro: è Eno a introdurre nel rock un’idea non lineare, quasi pittorica, della musica, praticamente un Kandinsky delle note.
Dopo due album pazzeschi (Roxy Music e For Your Pleasure), Eno lascia la band a causa di tensioni con Bryan Ferry, ed é allora che inizia il suo percorso personale e rivoluzionario.
I primi dischi da solista, Here Come the Warm Jets, Taking Tiger Mountain (By Strategy), Another Green World e Before and After Science, tutti nati negli anni '70, fondono pop d’avanguardia, sperimentazione elettronica e costruzioni melodiche sghembe, anticipando molte delle derive della new wave e del post-punk. In particolare Another Green World è un punto di svolta: le strutture cominciano a frammentarsi, lo spazio sonoro si dilata, e l’elemento atmosferico prende il sopravvento.
Nel 1975 un incidente automobilistico lo costringe a letto e lo induce a riflettere sul modo in cui la musica può riempire l’ambiente. Da questo nasce Discreet Music, manifesto della musica ambient, termine che egli stesso conierà, sonorità che dovevano migliorare l'atmosfera di un luogo o di una stanza, proprio come fanno l'illuminazione o la carta da parati. Seguiranno album fondamentali come "Ambient 1: Music for Airports", in cui il suono anziché invadere lo spazio lo arreda, in un equilibrio architettonico tra presenza e assenza, tra casualità e progettazione, tra vuoto e pieno.
Parallelamente, Eno si impone come produttore innovativo. Con David Bowie firma la trilogia berlinese "Low", “Heroes” e "Lodger" dove esplora ritmi spezzati, manipolazioni elettroniche e atmosfere sospese. Con i Talking Heads e David Byrne porta l’afrofunk nel rock occidentale e sviluppa il concetto di “studio come strumento compositivo” (Remain in Light, 1980).
Brian Eno è anche un teorico della creazione sonora. Le sue Oblique Strategies, un mazzo di carte concettuali per sbloccare la creatività in studio, sono state usate da artisti in ogni campo. È stato tra i primi a sperimentare la musica generativa, componendo brani non finiti, ma in continua trasformazione grazie ad algoritmi. Ha collaborato con sviluppatori software, ha progettato installazioni audiovisive in musei e gallerie di tutto il mondo, e ha pubblicato testi fondamentali come A Year with Swollen Appendices (1996).
Ma Brian Eno non è solo un pioniere ma un inventore, un architetto visionario che pone al centro la dimensione atmosferica e spaziale del suono e utilizza la musica per creare paesaggi sonori che regalano atmosfere rilassanti e suggestive.
Anni ruggenti i 60/70/80 in cui la musica e suoi artisti han regalato al mondo opere, vibrazioni ed emozioni irripetibili e immortali, opere che fluttuano nell'aria anche dopo l'apocalisse.
Giovanna Anversa















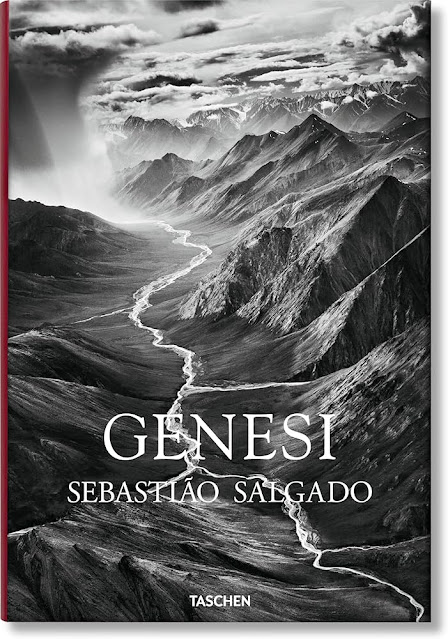




















%20%E2%80%A2%20Foto%20e%20video%20di%20Instagram.png)



-cf-cropped-153-0-895-675.jpg)






